 |
 |
|
|
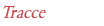
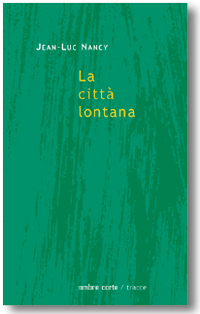
RASSEGNA STAMPA
|
|
|
|
|
La città lontana
|
|
Con una conversazione con l'autore di Pierangelo Di Vittorio
|
|
|
|
pp. 75
|
|
€ 7,50
|
|
isbn 88-87009-25-2
|
Il libro
A partire dal rifiuto di considerare Los Angeles come il paradigma della negazione della città, in queste pagine Jean-Luc Nancy ci invita ad abbandonare la l'armatura teorica dei nostri pensieri-riflessi sulla città, tutto quello, insomma, che ci fa troppo facilmente credere e dire che ci siano, distinte come il Bene e il Male, da un lato la "città" e dall'altro la "non-città", da un lato il "centro" e dall'altro la "periferia". È contro questa distinzione semplicistica tra il "luogo" (con tutte le sue implicazioni, l'alto-loco, lo spirito del luogo) e il "non-luogo" che combatte, in modo calmo ed efficace, La città lontana, testo nel quale si trova, come suo snodo decisivo, l'idea che la "città è un luogo in cui ha luogo qualcosa di diverso dal luogo"; formula che dev'essere accompagnata dal suo immediato corollario: "L'uomo abita en passant". In questo modo, viene abbandonata tutta la retorica dell'abitare e del risiedere, mentre viene affermato il diritto della città a non figurare, e quello dei suoi abitanti a non essere semplici figuranti.
L'autore
Jean-Luc Nancy (1940) insegna filosofia all'Università di Strasburgo. Tra le sue opere più importanti tradotti in italiano: La comunità inoperosa; Corpus; L'essere abbandonato; L'intruso; L'esperienza della libertà; e con Philippe Lacoue-Labarthe, Il mito nazi.
Indice del volume
Nota del curatore
Parte prima
Lontano...Los Angeles
Parte seconda
La città lontana
La città al di là del luogo
di jean-Christophe Bailly
Una conversazione con Jean-Luc Nancy
di Pierangelo Di Vittorio
Bibliografia di Jean-Luc Nancy
Una conversazione con Jean-Luc Nancy
D. Uno degli aspetti che, con maggiore frequenza, viene evidenziato nel processo di "globalizzazione", è il venir meno delle forme tradizionali della politica. Molti deprecano la crisi degli Stati nazionali, visti come ultimo baluardo a garanzia dei diritti di cittadinanza, sui quali sembra incombere la minaccia di una netta "autonomizzazione" della razionalità economica rispetto a quella politica. L'economico che divora il politico: è questa forse l'immagine che, più o meno segretamente, turba i nostri sogni... Tuttavia, il politico non sembra essere definitivamente uscito di scena, anzi riaffiora con la violenza di un "rimosso" nel cuore presuntamente pacificato del globo economico. Ed ecco che le città, da Seattle e Genova a New York, si trasformano d'un tratto, sotto i nostri occhi un po' attoniti, in enormi scene (nonché interminabili "cartoline" televisive) dell'antagonismo politico. È forse cominciata l'epoca delle città-teatro - penso precisamente alla natura "politica" del teatro -, delle città-eponimo di spettacoli politici di massa? Genova come Bayreuth? Si può pensare che la città riesca - in extremis, o forse già oltre ogni limite possibile, quindi nell'inquietante e nella dismisura - a riteatralizzare (a ripoliticizzare) il mondo?
R. Non chiamerei "politica" la trasformazione che tu evochi. Si tratta di un fenomeno molto più ampio o, se preferisci, radicale: tocca infatti le radici o i rizomi, oppure il tellurismo della o delle civiltà del mondo. Il dispiegamento della città al di là di tutto ciò che si chiamava "città", verso le "megalopoli" o le "conurbazioni"; la delocalizzazione dell'"urbano" sotto forma elettronica, informatica; il trasporto delle forme e dei ritmi cittadini attraverso presunti spazi "campagnoli": tutto questo corrisponde a una mutazione analoga a quella che, precisamente, moltissimo tempo fa, uscendo dagli Imperi e dalla pregnanza agricola sedentaria o nomade, fece ruotare la cultura mediterranea verso la "città [cité]": era la nascita dell'"Occidente". Oggi è la nascita di qualcos'altro: non si può che dire "un mondo". In questo nuovo quadro, la categoria di "politica", legata alla città [cité] e poi alle trasformazioni verso lo Stato, conserva una certa pertinenza, ma non bisogna chiamare "politica" tutto quello che attiene alla concatenazione, al dispositivo o alla rappresentazione (scena, immaginario, concetto) dell'essere-in-comune. Il politico, come tu dici, si sposta: ma non solo nello spazio e nella configurazione; si sposta in se stesso, si ritira da sé e in sé, fa cenno verso altre forme. Non possiamo chiamare "politico" ciò che non ha ancora delineato e demarcato il suo modo di governance. Perché una delle cose che diventano caduche è precisamente l'idea ossessiva di un'assunzione nel "tutto è politico", e di un correlativo riassorbimento del politico (dello Stato) che avrebbe dovuto dissolversi nel tessuto sociale totale. Direi, quindi, che la città, o la "supercittà", non fa "ritornare" il politico su un nuovo teatro, ma proietta altrove sia la politica sia il teatro, verso un altrove in cui i loro concetti già si deformano.
D, Tu vivi a Strasburgo, "città europea". A questo proposito vorrei domandarti: da un lato, come hai vissuto e vivi la tua attività filosofica in questa città, che è sì un incrocio di culture, ma che ha anche alle spalle una pesante storia di frontiera scavata nel cuore dell'Europa (l'Alsazia è stata, infatti, a lungo contesa fra la Francia e la Germania); dall'altro, e al di là dell'etichetta istituzionale (e turistica) che fa di Strasburgo una delle città simbolo del processo di unificazione, se ritieni che, oggi, parlare di "città europee" abbia un senso, e se sì quale.
R. Se Strasburgo è "città europea", mi sembra che lo sia in una maniera abbastanza rivelatrice di ciò che, oggi, è l'Europa (considerata come entità politica): a Strasburgo c'è un insieme di istituzioni (Parlamento, Consiglio, Corte), che rappresentano edifici (tutti raggruppati in uno stesso spazio), impieghi, circolazioni di funzionari e di deputati, e quest'insieme è abbastanza distaccato dalla città: non ne scalfisce né l'immagine, né il comportamento. L'Europa, a Strasburgo, è formale o astratta. Per il resto, è la città alsaziana che conosco da trent'anni, anche se si è trasformata, evolvendo, d'altronde, piuttosto in uno spirito germanico: non è né Lione, né Bordeaux, né Marsiglia. E non è "europea", sempre che esista qualcosa di simile. (Mi sembra che forse Bruxelles sia più europea; ma la conosco poco.) Una dozzina di anni fa è esistito a Strasburgo un Carrefour des littératures européennes: grande forum annuale, luogo di incontri e di eventi veramente europei (infatti, che cos'è principalmente e profondamente europeo se non la letteratura e l'arte?) e, più ampiamente, mondiali. C'erano le giuste premesse per creare, in questo spirito, un luogo permanente: tuttavia, per oscure ragioni di politica locale/regionale, che mi sfuggono, il progetto è naufragato dopo soli quattro anni. Non so se ci sono città "europee": direi che Londra, Parigi, Berlino, Bruxelles, Roma, Madrid, Amsterdam, Amburgo, Marsiglia, Genova, Milano sono le città europee. Fino a questo punto, non c'è mai stata Europa senza che una singolarità intraeuropea cristallizzasse l'essere europeo, se ne esiste uno. Diciamo che forse esisteva così, cristallizzato in lingue, nazioni, capitali, opere e individui distinti, fino alla prima guerra mondiale. Da allora, non c'è più Europa, ed è per questo che ci si è messi a cercarla. Mi domando se sia ancora possibile trovare l'Europa, ovvero se non ci troviamo già, per forza di cose, in una dimensione mondiale. Dopo tutto, il fenomeno delle megalopoli è veramente dispiegato, o in pieno sviluppo, piuttosto in Oriente, in America latina e, per certi versi, in Africa. Non so che cosa voglia ormai dire "città europea" (a meno che non significhi città-testimone del passato dell'Europa: Parigi, Londra, Vienna).
|
|

|
|
 |
 |
Tutti i diritti riservati. Copyright © 2005 ombre corte edizioni
Via Alessandro Poerio, 9
- 37124 Verona
- Tel. e Fax 045 8301735
|
|  |
 |