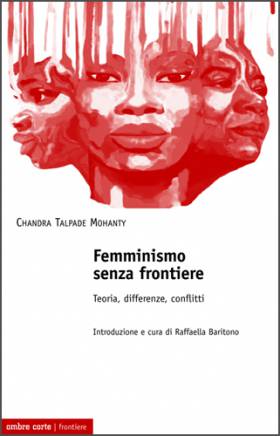Descrizione
Françoise Vergès
Una teoria femminista della vilenza
Per una politica antirazzista della protezione
Traduzione di Gianfranco Morosato
Il linguaggio ufficiale a proposito dell’uguaglianza uomini-donne è un repertorio di violenze: molestie, stupri, abusi, femminicidi. Queste parole descrivono una realtà crudele. Ma non ne nascondono un’altra, quella delle violenze commesse con la complicità dello Stato?
In questo libro, Françoise Vergès denuncia la svolta securitaria della lotta contro il sessismo. Focalizzandosi sugli “uomini violenti”, si omette di interrogare le fonti di questa violenza. Per l’autrice non ci sono dubbi: il capitalismo razziale, i populismi ultraconservatori, lo schiacciamento del Sud attraverso le guerre e i saccheggi imperialisti, i milioni di esiliati e di esiliate, l’aumento delle misure carcerarie, mettono le mascolinità al servizio di una politica di morte. Contro l’aria del tempo, Françoise Vergès ci esorta a rifiutare l’ossessione punitiva dello Stato, a favore di una giustizia riparatrice.
“La mia analisi non fornisce soluzioni per mettere fine alle violenze di genere e sessuali – la cui denuncia mostra oggi l’ampiezza –, ma vorrebbe contribuire alla riflessione sulla violenza come elemento strutturante del patriarcato e del capitalismo, e non come una specificità maschile. Questo libro cerca di immaginare una società postviolenta, non una società senza conflitti e contraddizioni, ma una società che non naturalizzi la violenza, che non la celebri, che non ne faccia il tema centrale della sua narrazione sul potere” (Françoise Vergès).
Françoise Vergès, femminista antirazzista, presidente dell’associazione “Décoloniser les Artsè”, è autrice di diverse libri e articoli sulla schiavitù coloniale, il femminismo, la riparazione, il museo. Tra questi: Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation et féminisme (2017) e il nostro Un femminismo decoloniale (2020).
Rassegna stampa
il manifesto – 4.8.2021
Françoise Vergès, altre narrazioni di cui appropriarsi
di Francesca Maffioli
L’ultimo libro della politologa e attivista antirazzista francese Françoise Vergès arriva in Italia, edito da Ombre corte. Una teoria femminista della violenza. Per una politica antirazzista della protezione (traduzione di Gianfranco Morosato, pp. 150, euro 13,50) segue non solo cronologicamente Un femminismo decoloniale (Ombre corte, 2020 – una intervista su queste pagine un anno prima, ndr) perché sono proprio le conclusioni, potremmo anche chiamarli i passi del pensiero dei femminismi decoloniali e antirazzisti, a scandire quel movimento di riappropriazione culturale che desidera ribaltare la narrazione occidentale del mondo.
Una narrazione per cui le violenze inferte alle donne sono sostenute dal patriarcato, ma in cui Stato e capitale sembrano non avere responsabilità in merito. Per Vergès invece una politica decoloniale e antirazzista della protezione dovrebbe essere «risolutamente anticapitalista e depatriarcalista perché vede in questi regimi il crogiolo della violenza sistemica contro le donne».
RICONOSCERE IL BISOGNO di protezione degli esseri umani non significa rendere i soggetti delle vittime potenziali; riconoscerne la vulnerabilità significa ritenere la debolezza non un fallimento ma il riconoscimento della fallacia di tutta la mitologizzazione costruita attorno all’idea di «corpo performante». Vergès spiega in maniera convincente come questa narrazione del corpo performante non riveli che una porzione faziosa di tutta la storia: le prestazioni dell’uomo bianco, in pieno possesso di una forza fisica normata come maschile, sono consentite da tutto il carico sui corpi razzizzati (il cui lavoro è invisibile perché invisibilizzato). Il nesso di vulnerabilità a cui fa riferimento la politologa è molto lontano dalla pur variegata galassia dei fenomeni di vittimizzazione cui sono soggette le donne: integrare la consapevolezza che il proprio corpo potrebbe e con l’avanzare degli anni sarà inevitabilmente vulnerabile non corrisponde a sentirsi come vittime potenziali di atti di violenza.
Questa stessa vittimizzazione rappresenta a torto, per Vergès, l’unico mezzo per giustificare gli atti di difesa che le donne possono apprendere a compiere per difendersi: «Una donna può uccidere per difendersi ed essere perdonata dalla società e dallo Stato solo se incarna la figura della vittima totale». Citando la filosofa Elsa Dorlin, Vergès guarda invece all’organizzazione dell’autodifesa come a un «processo di riumanizzazione», volto a superare «la paura imposta da secoli di oppressione, di uccisioni, torture, riduzioni al silenzio» e atto a potenziare l’energia necessaria per combattere il dominio e l’oppressione.
«Non si tratta di essere a favore o contro la violenza, ma di respingere la condanna borghese della violenza degli oppressi e di favorire una molteplicità di tattiche e dunque l’autonomia e la flessibilità delle lotte». Per spiegare cosa intende per depatriarcalizzazione e decolonizzazione della violenza, Françoise Vergès elenca il debito nei confronti delle militanti indigene del Centro e Sud America.
TESSENDO UNA RETE di esempi radicati nelle storie di esperienze di comunità e di gruppi di attiviste e attivisti, mostra che un’alternativa alla protezione patriarcale e carceraria è possibile. Quando Vergès afferma che le politiche neoliberiste sono razzializzate non vuole negare che anche le donne non razzizzate siano oggetto di violenze; vuole invece provare a analizzare la protezione dal punto di vista della classe, della razza e dell’eteronormatività mostrando come in questa fase di riattualizzazione necroliberale le mascolinità violente siano al servizio di una politica di morte. E vuole altresì comprendere i limiti del cosiddetto femminismo carcerario e punitivo, prodotto del femminismo universalista e civilizzatore, che secondo Vergès – e la sociologa Elisabeth Bernstein prima di lei – penalizza gli atti senza porsi nella dimensione conoscitiva di coloro che sono criminalizzati.
Come già in Un femmismo decoloniale, lo sguardo di Françoise Vergès non esita a fare riferimento a quella «futurità» che è capace di sfibrare le maglie del pensiero neoliberista, generatore di violenza. Riuscire a cogliere e riconoscere l’intreccio tra rapporti materiali nelle relazioni di dominio consente di avere sguardo su sistemi alternativi in cui la giustizia per le donne significa una giustizia per tutti i soggetti abusati. Questo appello alle feminist futurities è quello che troviamo nella parte finale del saggio di Vergès.
LA STUDIOSA non esita allora a fare riferimento alla letteratura, come bacino ferace in cui ravvisare visioni di mondi alternativi. Prendendo ad esempio il capovolgimento radicale del sistema di dominazione descritto da Naomi Alderman nel suo romanzo Ragazze elettriche (2016), ne coglie i limiti: anche se propone delle soggettività potenti contrarie alle rappresentazioni vittimizzanti delle donne, è il «potere elettrico» di dare la morte all’altro a garantire il rovesciamento sistemico.
Per «vincere la paura senza usare la paura e il terrore, pur abbattendo la dominazione» è invece necessario immaginare il mondo andando oltre l’idea di una violenza speculare. Proprio quello che fa la scrittrice di fantascienza afroamericana Octavia E. Butler nel Ciclo delle Parabole (1993-1998). Fare resistenza per Butler significa infatti creare e ricreare legami affettivi in una società attraversata dalla paura ma non cieca alle utopie di liberazione: «A capo della resistenza, Olamina reinventa ciò che fa famiglia e crea una comunità per – salvare e definire l’umanità». Françoise Vergès tramite Octavia E. Butler vuole mostrare come tale liberazione non possa essere definita nei termini dei pure esaltanti superpoteri individuali, ma piuttosto secondo una dimensione collettiva dell’impegno capace di fare comunità.
Nazione indiana
Una teoria femminista della violenza. Intervista a Françoise Vergès
di Jamila Mascat
Saggista e militante femminista decoloniale, Françoise Vergès ha da poco pubblicato in Francia un libro intitolato Une théorie féministe de la violence. Pour une politique anti-raciste de la protection (La Fabrique, 2020). In questa intervista l’autrice riflette sul tema della violenza nel panorama femminista contemporaneo, denunciando i limiti e le contraddizioni delle correnti femministe cosiddette “punitive e carcerali” che invocano l’intervento repressivo dello Stato come unico rimedio contro le violenze di genere. Che cosa significa, invece, per le femministe anticapitaliste e antirazziste pensare la protezione e la difesa dei propri corpi altrimenti?
JM: Cominciamo proprio dal titolo del tuo ultimo libro Une théorie féministe de la violence: che cosa significa pensare la violenza strutturalmente radicata nelle società contemporanee a partire da una prospettiva femminista e decoloniale? E in che misura una simile prospettiva è in grado di apportare nuovi elementi di comprensione?
FV: Per prima cosa si tratta di precisare che la violenza distruttiva e sterminatrice che prolifera nelle società odierne non ha nulla di nuovo, così come le violenze sessuali e sessiste. Il dato di novità è legato all’intensità, al modo in cui il capitalismo neoliberale e finanziarizzato si lancia alla rincorsa di profitti esorbitanti, l’estrattivismo che ne deriva, le guerre economiche che ne conseguono contro le popolazioni del Sud Globale e poi anche più recentemente contro i paesi del Nord del mondo (basti pensare al caso della Grecia), la crisi climatica, la devastazione sistematica delle terre da parte dell’agrobusiness, il prosciugamento del suolo e del sottosuolo, la privatizzazione e la militarizzazione esponenziale dei mari e degli oceani, i femminicidi, le politiche assassine condotte contro militanti indigeni e antirazzist*, la negrofobia senza limiti, l’islamofobia, la caccia a* migranti, ecco, tutto questo dice di una forte accelerazione delle violenze razziste e sessiste e di un’intensificazione dello stato di guerra permanente contro intere popolazioni. >> continua a leggere <<
UN ASSAGGIO
Indice
9 Introduzione
“Lo Stato oppressore è un macho stupratore”; Una politica di protezione femminista e decoloniale
19 Capitolo primo. La violenza neoliberale
Movimenti femministi e ascesa del neoliberalismo; Capitalismo gore, stupro e politica dell’omicidio; Violenza del mercato e della precarietà; Una protezione illusoria: tre storie di ordinaria violenza
50 Capitolo secondo. L’approccio civilizzatore alla protezione delle donne
Femoimperialismo e protezione delle donne del Sud del mondo; Genealogia di un ambiente ostile; Il divieto di fare comunità
75 Capitolo terzo. Il vicolo cieco del femminismo punitivo
“La paura deve cambiare campo”; Il desiderio di vendetta, la sete di punizione; Per finirla con il sistema penale: i vicoli ciechi del femminismo carcerario; Le prigioni non ci salveranno né dal patriarcato, né dalla violenza; Le femocratiche socialiste, tra “putofobia” e ideologia della sicurezza; Proteggere lo spazio pubblico, escludere le persone razzizzate e i poveri; Rinchiudere, punire
120 Conclusione. Il femminismo decoloniale come utopia
Un mondo guidato dall’avidità e dal potere; Bruciate!; Vite ferite; “Non perdere mai l’occasione di approfittare di una buona crisi”; Una politica femminista decoloniale della protezione, antirazzista e transfrontaliera; Violenza di Stato/Difesa autonoma
Introduzione
“Lo stato oppressore è un macho stupratore”
“Lo stupratore sei tu/ Sono la polizia, i giudici, lo Stato, il Presidente/ Il patriarcato è un giudice che ci giudica dalla nascita/ E la nostra punizione è questa violenza che vedi/ Sono i femminicidi, l’impunità degli assassini/ È la sparizione, è lo stupro/ E la colpevole non sono io, i miei vestiti o il luogo/ Lo stupratore eri tu/ Lo stupratore sei tu/ Sono la polizia, i giudici, lo Stato, il Presidente/ Lo Stato oppressore è un macho stupratore”. Queste parole hanno scandito la performance militante, di risonanza mondiale, Un violador en tu camino (“Uno stupratore sulla tua strada”). Le autrici del testo, Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor e Lea Cáceres – quattro delle fondatrici del collettivo femminista cileno Las Tesis –, puntano il dito contro i veri responsabili degli stupri e dei femminicidi: la polizia e lo Stato. Questa canzone, intonata in pieno movimento sociale contro le politiche neoliberiste da un collettivo che partecipa alle manifestazioni, in un contesto di forti violenze da parte della polizia, testimonia il rifiuto di dissociarsi dal movimento con il pretesto della protezione delle donne: “Non si può dire che la polizia cilena vigili sulle donne, per questo li accusiamo, per evidenziare la contraddizione, come una forma di ironia”, riferiscono al quotidiano “Verne”. Come sottolinea la filosofa Elsa Dorlin, poiché lo Stato è “il principale istigatore delle disuguaglianze” e “precisamente colui che arma chi ci colpisce”, è “inutile chiedergli giustizia perché è il primo organismo che istituzionalizza l’ingiustizia sociale”. In questo senso, la lotta contro le violenze non può prescindere né da una critica di ciò che lo Stato promuove e legittima né da una critica delle rivendicazioni femministe rivolte allo Stato e alla giustizia. Come possiamo rispondere alle multiformi violenze sessiste e sessuali quando i “corpi razzizzati, i corpi femminili, i corpi poveri o i corpi giovani hanno meno valore in questa fase di riattualizzazione necro-liberale”, in quanto corpi sacrificabili?