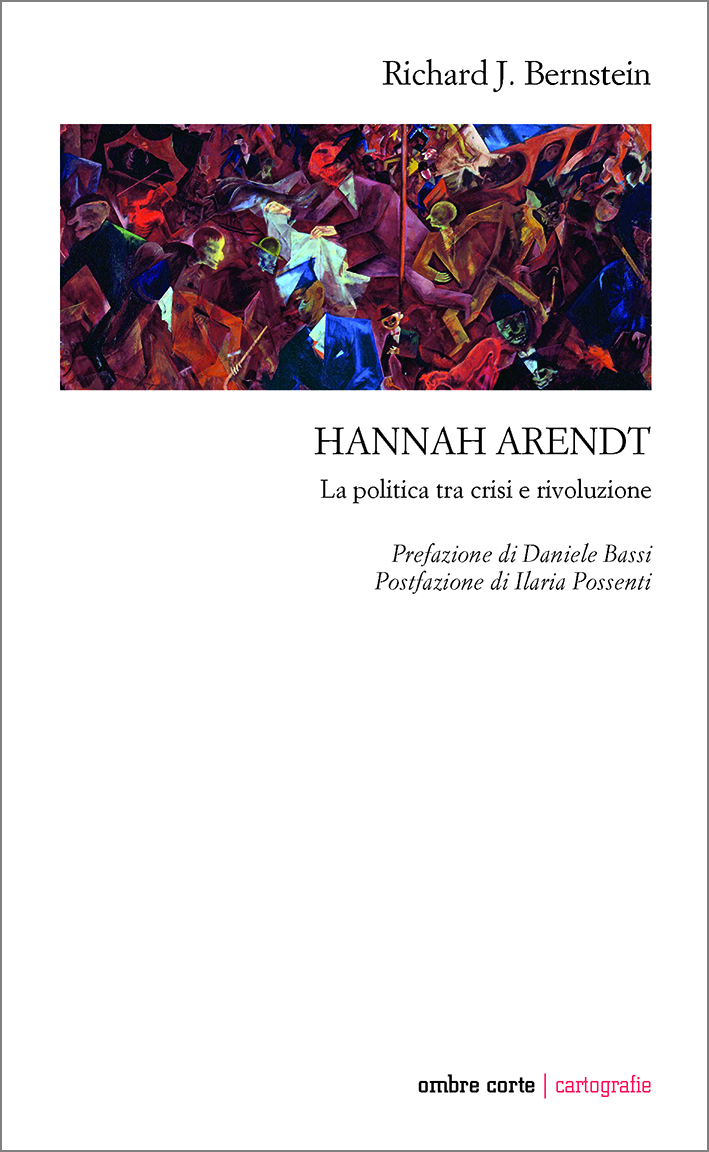Descrizione
Richard J. Bernstein
Hannah Arendt. La politica tra crisi e rivoluzione
Traduzione e Prefazione di Daniele Bassi
Postfazione di Ilaria Possenti
Perché leggere Hannah Arendt oggi? Perché, sostiene Bernstein, le sue penetranti intuizioni ci aiutano a pensare sia all’oscurità dei nostri tempi che alle fonti di illuminazione. In questo suo agile e acuto lavoro il filosofo statunitense ne esplora il pensiero sull’apolidia, i rifugiati e il diritto ad avere diritti; la banalità del male e le complesse relazioni tra verità, menzogna, potere e violenza; la tradizione dello spirito rivoluzionario e l’urgenza che ciascuno di noi si assuma la responsabilità della propria vita politica.
Senza risparmiare critiche agli aspetti più controversi dell’opera di Arendt, Bernstein le attribuisce un duplice merito: da un lato, quello di aver riconosciuto i molteplici sintomi di una radicale crisi della politica moderna, anche per quanto riguarda le sue aspirazioni democratiche; dall’altro, quello di aver seguito con grande originalità teorica le tracce di una tradizione alternativa, producendo “una delle analisi più raffinate e suggestive della politica partecipativa”, che integra “i concetti di dibattito, pluralità, isonomia, concreta libertà pubblica, felicità pubblica, potere comune”.
Per queste vie, Arendt solleva nuove domande ed elabora categorie inedite, associando alla critica della modernità la riflessione sul senso e sulla dignità di una politica aperta allo “spirito rivoluzionario” e alla possibilità di “dare inizio a qualcosa di nuovo”.
Richard J. Bernstein (New York 1932-2022), filosofo ed esponente di spicco del cosiddetto neopragmatismo, si è instancabilmente dedicato al dialogo tra le principali teorie critiche contemporanee, e confrontato a più riprese con autori come Habermas, Gadamer, Derrida, Arendt. Tra i suoi testi tradotti in italiano: La nuova costellazione (Feltrinelli, 1994), Sul pragmatismo (il Saggiatore, 2015) e, su temi arendtiani, Provocazione e appropriazione: la risposta a Martin Heidegger, in Hannah Arendt (Bruno Mondadori, 1999) e Ripensare il sociale e il politico (“aut aut”, 386, 2020).
UN ASSAGGIO
Indice
7 Prefazione
di Daniele Bassi
19 Ringraziamenti
21 Introduzione
27 Apolidi e rifugiati
36 Il diritto ad avere diritti
46 Critica del sionismo: un’opposizione leale
55 Razzismo e segregazione
64 La banalità del male
71 Verità, politica e menzogna
83 Pluralità, politica e libertà pubblica
98 La Rivoluzione americana e lo spirito rivoluzionario
108 Responsabilità personale e politica
113 Postfazione. Pensare il politico con il sociale.
Arendt e Bernstein
di Ilaria Possenti
Prefazione
di Daniele Bassi
“Qual è l’oggetto del nostro pensare? L’esperienza, e nient’altro!”. Così affermava Hannah Arendt il 24 novembre del 1972 a Toronto, intervenendo a un convegno a lei dedicato e intitolato “The Work of Hannah Arendt”. Già parecchi anni prima, nell’introduzione di The Human Condition, l’autrice presentava la sua opera filosoficamente più importante dichiarando di porsi un obiettivo “molto semplice: niente di più che pensare a ciò che facciamo”. Il senso del termine “esperienza”, che Arendt propone come oggetto del pensiero non va dunque ricondotto a dispute di ordine gnoseologico. Piuttosto, e comunque solo in parte più “semplicemente”, si riferisce letteralmente “a ciò che facciamo”, non alla nostra vita contemplativa ma alla nostra vita activa, la cui massima espressione si dà nell’azione politica. Richard Bernstein, per motivi che verranno presto esplicitati, nel suo lungo confronto con l’opera arendtiana non ha mai dimenticato, né smesso di valorizzare, questa postura intellettuale che radica la riflessione teorica nella dimensione pratico-politica delle nostre esistenze. Non è casuale, infatti, che il suo saggio del 2018 sull’attualità di Arendt, qui presentato in traduzione italiana, si apra considerando che “una caratteristica peculiare del pensiero arendtiano [è] la convinzione che una riflessione, per essere seria, debba fondarsi sull’esperienza vissuta”.
Da parte sua, nell’introduzione di The New Constellation (1991), Bernstein ha scritto che “la preoccupazione più persistente e pervasiva” di tutti i suoi studi “è la questione (o le questioni) della prassi”. Per quanto sia sempre stato un attento lettore di Marx, quest’ultima dichiarazione va ricondotta principalmente all’influenza del pragmatismo classico – determinante più di qualunque altra nel suo percorso intellettuale. La rivendicata predilezione per gli esiti pratici della speculazione teorica è senza dubbio la cifra del debito che lega il professore della New School alla corrente filosofica fondata in America a cavallo tra Otto e Novecento da pensatori come Charles Peirce (1839-1914), William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952) e George Herbert Mead (1863-1931). Questi autori, polemizzando in primo luogo con le dottrine del determinismo meccanicista, tentavano di mantenere e implementare una concezione del mondo capace di contemplare l’irriducibilità del caso e della contingenza. Contro il cartesianesimo e la sua enorme influenza sulla filosofia moderna, rifiutavano inoltre la presunzione di un soggetto solipsistico che tramite il cogito può pervenire ad una conoscenza intuitiva diretta. Al di là di più ampie argomentazioni epistemologiche e gnoseologiche, il cui approfondimento eccederebbe gli scopi di questa introduzione, le implicazioni che Bernstein valorizza di tale impostazione sono quelle politiche: i padri del pragmatismo sono stati tra i primi a dare dignità filosofica al concetto di “pluralismo”, conferendo al riconoscimento della pluralità del reale e della conoscenza una forte tensione etica, fondata sul concetto della “umana fallibilità”. È soprattutto con Dewey e Mead, numi tutelari di Bernstein ed entrambi attivamente impegnati in favore della democrazia e dei diritti civili, “che gli aspetti sociali e politici del pragmatismo sono messi in primo piano”.
Si tenga inoltre presente che Bernstein, insieme ad autori quali Richard Rorty e Hilary Putnam, è considerato uno dei protagonisti della cosiddetta “svolta neopragmatica” della filosofia americana dell’ultimo quarto del xx secolo. In The New Constellation, a questo proposito, Bernstein osserva come la lunga egemonia della filosofia analitica nelle accademie statunitensi sia stata messa in discussione nel corso degli anni Ottanta da un fermento pluralistico che è andato via via affermandosi a cominciare dal decennio precedente, “come dimostrano le questioni del femminismo e delle minoranze”, rivendicando “un nuovo stato d’animo intellettuale di fluidità e di abbattimento di steccati”. È quindi particolarmente significativo che proprio in un capitolo di The New Constellation, dedicato al tema dell’alterità [otherness], la concezione arendtiana della pluralità umana si affermi come categoria filosofica imprescindibile. In The Human Condition, in pagine particolarmente care all’autore neopragmatista, com’è noto Arendt insiste sull’intrinseco paradosso della pluralità: “il duplice carattere dell’eguaglianza e della distinzione”. La condizione umana è insomma la “paradossale pluralità di esseri unici”, eguali e al tempo stesso in grado di distinguersi gli uni dagli altri nel corso delle loro interazioni. Una premessa teorico-antropologica di questo tipo implica da un lato il rifiuto delle concezioni individualiste dell’umano e, dall’altro, soprattutto dopo l’abisso totalitario, comporta un instancabile sforzo – teorico quanto pratico – volto a non sacrificare mai le unicità alla massa, le singolarità a un indistinto corpo collettivo. Politicamente parlando, assumere fino in fondo il tema dell’uguaglianza e della distinzione significa infine promuovere un tipo di democrazia radicale che Arendt, in senso genealogico, riconduce all’intuizione greca dell’isonomia – l’autogoverno degli eguali.