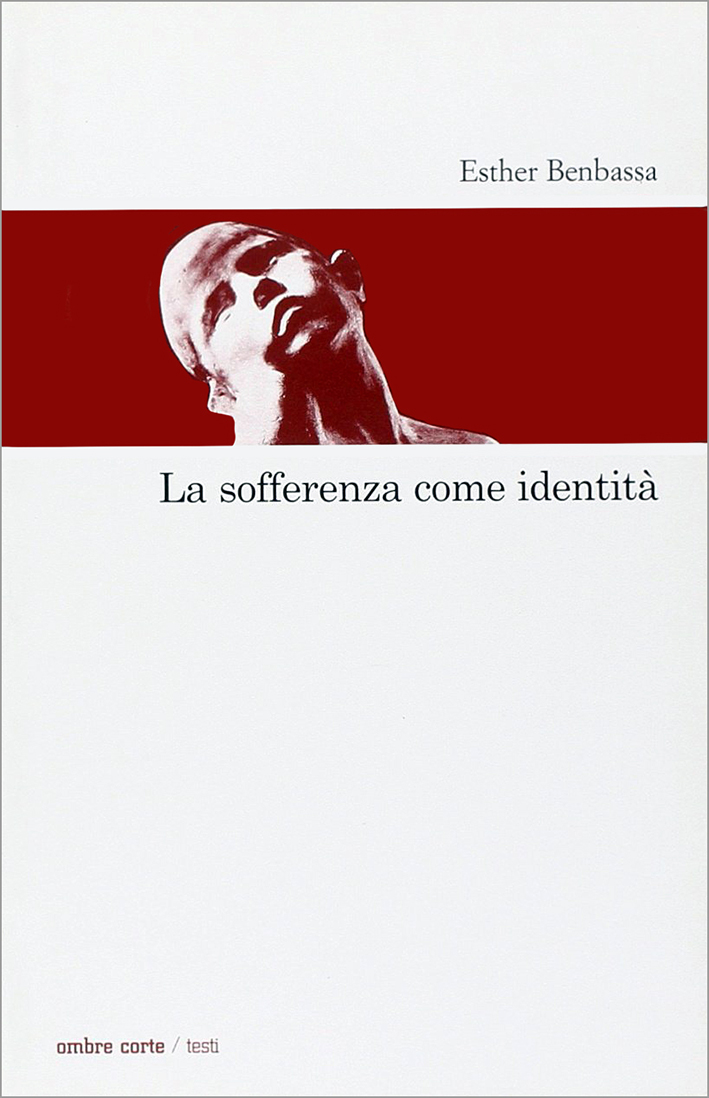Descrizione
Esther Benbassa
La sofferenza come identità
Quest’opera evidenzia come nel mondo ebraico, dopo le stesse fondazioni bibliche, la sofferenza, le sue rappresentazioni e la sua ritualizzazione abbiano fabbricato, nel corso dei secoli, non solo la storia di un popolo e di una religione ma anche, e soprattutto, l’idea che questo popolo e questa religione si sono fatti della loro storia. Il libro segue questo percorso fino alle sue ultime metamorfosi e analizza il legame indissolubile che alla fine si è venuto a stabilire tra il genocidio e lo stato d’Israele, la sua politicizzazione, la sua generalizzazione e la sua recente trasformazione in una religione accessibile a tutti, un ebraismo “dell’Olocausto e della Redenzione” – dove Redenzione sta per creazione dello stato ebraico. Ad di là di questo caso specifico, il volume intende fornire alcune chiavi di lettura per comprendere anche gli attuali atteggiamenti nei confronti della sofferenza – atteggiamenti molteplici, complessi e universali, di cui la memoria del genocidio è divenuta il paradigma.
Non si tratta dunque di un libro sull’Olocausto, né soltanto di un libro sul ebraismo. Diversamente, esso si pone come una riflessione storica sull’universalità della sofferenza. Leggere la sofferenza, significa anche leggere le traiettorie memoriali e identitarie della contemporaneità, necessarie e inevitabili quanto invasive. E la sofferenza eretta a identità rappresenta tanto lo specchio del nostro presente, quanto la prefigurazione del futuro che ci accingiamo a costruire. Un futuro di vittime, ripiegate sul loro dovere di memoria, il cui unico sogno è un impossibile oblio… o forse un futuro finalmente “amnesiaco”, che affida alla storia – non agli storici – il deposito dei nostri passati di sofferenza.
Esther Benbassa è docente di storia ebraica moderna all’École pratique des hautes études (Sorbonne, Parigi) e intellettuale presente nel dibattito pubblico. Tra le sue numerose opere, tradotte in diverse lingue, ricordiamo: Gli ebrei hanno un futuro? L’ebraismo tra modernità e tradizione (con Jean-Christophe Attias, Dedalo 2003), Storia degli ebrei sefarditi. Da Toledo a Salonicco (con Aron Rodrigue, Einaudi, 2004).
RASSEGNA STAMPA
il manifesto – 11 febbraio 2009
La memoria in difesa del presente. Identità inventate
di Enzo Traverso
L’importante saggio di Esther Benbassa su «La sofferenza come identità». Una coraggiosa denuncia da parte della docente francese di storia ebraica sull’uso pubblico della Shoah per legittimare qualsiasi operato dello Stato di Israele
A partire dal Medioevo, la nostra rappresentazione della sofferenza è a filtrata da lenti cristiane. L’Europa pacificata e secolarizzata del secondo dopoguerra ha tuttavia rimosso la visione cristiana del martirio come sofferenza interiorizzata, liberatrice e redentrice. Gli ultimi martiri laici, vittime volontariamente immolate nel compimento di un sacrificio offerto alla patria, sono i combattenti delle due guerre mondiali. Da allora, il martire è diventato una figura anacronistica, incomprensibile e guardata con sospetto.
Oggi, i terroristi islamici che muoiono compiendo attentati suicidi sono visti come rappresentanti di un fondamentalismo fanatico e oscurantista. Raramente sono messi in rapporto a una lunga storia che travalica le frontiere religiose e racconta atti motivati dalla disperazione, in cui il sacrificio di sé diviene un’affermazione di dignità e di rivolta, quando tutte le altre modalità d’azione sembrano precluse. Così Flavio Giuseppe ha tramandato la storia della rivolta ebraica di Masada, nel 74 dopo Cristo, conclusa con un suicidio collettivo di fronte all’assedio romano. Non è escluso che uno stato d’animo analogo sia affiorato tra i combattenti palestinesi di Gaza, durante l’invasione delle scorse settimane. È uno dei meriti dell’ultimo libro di Esther Benbassa – che conferma una volta di più di essere una studiosa originale, brillante e anticonformista – l’aver messo in luce le affinità che legano la figura ebraica del «profeta-martire» – particolarmente diffusa ai tempi delle Crociate – a quella del martire islamico odierno, entrambe eredi di una tradizione che risale all’Antichità greco-romana (La sofferenza come identità, traduzione dal francese di Massimiliano Guareschi, Ombre corte, pp. 216, euro 19,50).
Tradizioni del martire
Al centro della sua analisi è tuttavia la rappresentazione della storia ebraica come tragica epopea di una comunità unita e perpetuata nel dolore. Si tratta di una rappresentazione polivalente, perché definisce al contempo l’immagine degli ebrei nel mondo dei gentili e un’auto-percezione ebraica del proprio passato, di cui non bisogna sottovalutare le conseguenze. Oggi, questa rappresentazione tende a diventare l’identità di una minoranza non più unita da vincoli religiosi. L’unione forgiata da un passato condiviso di sofferenze prende il posto di una fede che si tramanda come rito ma non fonda più né una visione del mondo né una condotta di vita. La «sofferenza come identità» è la tradizione «inventata» – nel senso suggerito da Eric Hobsbawm e Terence Ranger – di una minoranza la cui esistenza non ruota più intorno alla sinagoga e i cui punti di riferimento più saldi sono diventati due: la memoria della Shoah e l’identificazione, più emotiva che razionale, allo Stato di Israele, uno Stato che della Shoah si vuole al contempo figlio e redentore.
Specchio di questa storia «lacrimale» è lo sguardo sofferente di Elie Wiesel, premio Nobel della pace, figura «cristica» che riassume in sé il dolore ebraico e la volontà occidentale di espiazione per un passato millenario di antisemitismo. Ma non si tratta di una visione nuova, sorta in questa svolta di secolo. Ha una lunga storia di cui Esther Benbassa ricostruisce magistralmente il percorso.
Le lacrime del passato
Ne troviamo le prime tracce nel Rinascimento quando Joseph Ha-Cohen, ebreo cacciato dalla Spagna della Reconquista, pubblica in Italia La valle dei pianti (1558). Nell’Ottocento, il secolo dell’Emancipazione, essa è riformulata dai primi storici ebrei. Heinrich Graetz, figura di spicco della Wissenschaft des Judentums, vuole fare della storia ebraica una scienza rigorosa, sottraendola alla memoria che fino a quel momento ne era stata depositaria. Negli anni Cinquanta dell’Ottocento, Graetz pubblica una monumentale Storia degli ebrei concepita come un lungo martirologio provvidenzialmente concluso dall’Emancipazione, fine di una lunga catena di sofferenze e punto di partenza della vera storia, in cui gli ebrei cessano di essere vittime e diventano attori del proprio destino.
Questa visione lacrimale del passato, che nega ogni autonomia al mondo ebraico anteriore all’emancipazione, riducendolo a specchio di un’oppressione subita, contiene inevitabilmente molte approssimazioni. Ad esempio, presenta i ghetti come luoghi di reclusione coatta – ciò che diventarono nel Medioevo – sottovalutandone la nascita come spazi di vita comunitaria e di separazione sociale creati volontariamente. Questa visione accompagna tuttavia il secolo dell’assimilazione ebraica in Europa occidentale, dove la tendenza dominante consiste a rimuovere l’antisemitismo dal presente, considerandolo come un residuo del passato, inevitabilmente destinato a scomparire in un mondo regolato dal diritto e fecondato dai Lumi. Il filosofo neokantiano Hermann Cohen, convinto assertore della «simbiosi ebraico-tedesca», ne fornisce nel 1919 una definizione paradigmatica: «Israele è stato fino ad oggi, nel corso della sua storia, un popolo della sofferenza. La sofferenza è diventata la sua energia vitale».
Prigioniera di un’idea di Progresso tipicamente ottocentesca, questa narrativa ottimista e rassicurante non poteva sopravvivere al trauma del nazismo, sorto non nell’Europa dei pogrom ma nella patria dell’Aufklärung. La concezione lacrimale della storia ebraica riaffiora tuttavia nel dopoguerra con finalità diverse. Da una parte, si fa corollario di una concezione della storia dell’antisemitismo come movimento lineare che collega le persecuzioni del Medioevo cristiano alle camere a gas hitleriane. La storia ebraica diventa allora un interminabile sentiero di sofferenze, di cui i campi di sterminio sono l’epilogo logico e coerente. Sul piano storiografico, questa visione ispira una fortunata Storia dell’antisemitismo di Léon Poliakov ma è invece criticata, fin dagli anni Quaranta del Novecento, dal decano degli studi ebraici di Columbia University, Salo W. Baron. D’altra parte, essa partecipa alla costruzione di una memoria pubblica dello sterminio nazista e alla sua trasformazione in elemento fondante di una coscienza storica condivisa. Sorge allora una teologia del genocidio come evento unico, acme di un lungo cammino di sofferenza, evento sacro e perciò distinto da tutte le altre violenze della storia. Si profila anche, parallelamente, una sorta di teodicea laica che fa d’Israele, lo Stato nato come risposta allo sterminio, un’entità altrettanto sacra.
Golgota della modernità
È soprattutto il teologo canadese Emil Fackenheim – richiamandosi alla teoria cabalistica del tikkun, la riparazione di «un danno cosmogonico originario» – ad aver presentato Israele come atto redentore delle sofferenze subite dagli ebrei, sacro allo stesso titolo del tragico evento che lo ha generato. Nel mondo cristiano, questa visione si fa strada attraverso una rappresentazione della storia ebraica come martirologio culminato nella figura dell’«ebreo crocifisso». Un grande artista come Marc Chagall vi ha contribuito dipingendo una famosa serie di allegorie cristologiche. Nel 1979, Giovanni Paolo II ha definito Auschwitz un «Golgota del mondo contemporaneo».
In Israele, paese che ha accolto un gran numero di superstiti dell’Olocausto, l’introiezione di questa identità fondata sulla sofferenza data dagli anni Sessanta. La visione teologica di Auschwitz si traduce allora in una religione politica che, al di là dello Stato, avvolge di un’aura sacra il suo esercito e ne santifica le violenze. La memoria dell’Olocausto, conclude Esther Benbassa, permette a Israele di «proclamare la propria innocenza e rettitudine» in nome di una sofferenza che garantirebbe agli ebrei «l’accesso a una sorta di torre d’avorio morale». Segue una citazione particolarmente pertinente di Shlomo Ben-Ami, ex ministro degli esteri israeliano, che invitava i suoi concittadini ad abbandonare la postura delle vittime e a smetterla di paragonare Arafat, Sadam Hussein e Ahmadinejad a Hitler. Così facendo, aggiungeva, «siamo noi a banalizzare la Shoah».
A guardia della storia
La fine del «secolo breve» ha generato una nuova percezione del passato al centro della quale troneggiano le vittime, un tempo ignorate e oggi fonte di una nuova ermeneutica della storia. Questo mutamento – al quale andrebbero dedicate ben altre attenzioni – porta con sé il pericolo della semplificazione e della demagogia. Particolarmente odioso è il tentativo di chi, previa appropriazione della memoria, cerca di legittimare, in nome delle vittime del passato, una violenza creatrice di nuove vittime nel presente. A differenza dei vinti, le vittime non sono attori della storia, soltanto oggetto di compassione e soccorso filantropico.
Nel corso degli ultimi decenni, l’umanitarismo è stato il vettore di una ricolonizzazione dello sguardo occidentale sulle sofferenze del mondo (almeno finché Hugo Chavez ed Evo Morales non hanno proposto una soluzione alternativa alle guerre umanitarie e ai concerti contro l’Aids). La sofferenza ebraica sfugge tuttavia a questo clichè. L’Olocausto conferisce a Israele lo statuto di rappresentante delle vittime e la sua appartenenza al mondo occidentale lo legittima come redentore armato dalla testa ai piedi. Tsahal cessa allora di essere un esercito d’occupazione per diventare l’organo di autodifesa di un popolo di vittime, unito dalla storia di un lungo martirio. «Il nostro esercito è puro», affermano i generali israeliani in Tsahal, un film che Claude Lanzmann ha concepito come epilogo di Shoah.
Da anni, Esther Benbassa denuncia questo genere di mistificazioni. È un’ebrea scomoda, tanto più scomoda quanto più autorevole è la sua voce nel campo degli studi ebraici. La tradizione alla quale appartiene non è quella del misticismo della sofferenza, piuttosto quella del pensiero critico.
“L’indici dei libri”
Recensione di Claudio Vercelli
Il nesso tra vita e identità può essere dato dal dolore? Ciò che unisce l’esistenza con il senso che intendiamo attribuirle è veicolato dal codice della sofferenza? Se lo domanda Esther Benbassa, soffermandosi sulla storia ebraica e su ciò che ha tenuto unite, nel corso del tempo, comunità diasporizzate, altrimenti destinate a subire soverchianti processi di assimilazione nonché di prevedibile estinzione socioculturale. Del libro diciamo subito che, se convincono alcuni riscontri, l’impianto generale può tuttavia sollevare qualche perplessità, soprattutto dove l’autrice si adopera in una reductio ad unum che sembra volere rileggere il passato perlopiù alla luce delle polemiche che agitano il presente. Segnatamente, un presente che ha il nome di Israele. La tesi di fondo è che la storia ebraica sia stata vissuta dai medesimi protagonisti come un’interminabile epopea animata da un ethos del dolore, costantemente sospesa tra persecuzione e martirio. L’eterna narrazione della prima come del secondo ha confortato un meccanismo di rispecchiamento solidale: quello dell’autopercezione tra gli ebrei così come della rappresentazione tra i non ebrei, coincidenti entrambi nel definire un perimetro identitario giudaico basato sulla sofferenza.
Benbassa stabilisce un continuum, soprattutto per quel che concerne le vicende degli ebrei askenaziti che dal passato confluiscono nel presente dello Stato d’Israele.
Da ciò alla teodicea il passo è breve e si compie nella religione politica che informa di sé l’identità israeliana quand’essa si declina nel meccanismo che celebra nel medesimo tempo la caduta e la redenzione come due facce della stessa medaglia, laddove la caduta è la Shoah, culmine di una traiettoria antisemitica che avrebbe inevitabilmente portato al massacro di massa, e la redenzione è data dalla presenza, in questo non meno inesorabile, dello stato degli ebrei. Una sorta di provvidenza laica, in buona sostanza, sarebbe alla radice di questa costruzione ideologica che si fa filosofia della storia. L’autrice applica il dispositivo identitario, implicato dall’assunzione del ruolo storico di vittima, al modo in cui gli ebrei non solo si sono fatti soggetto di storia, ma hanno reso essa stessa oggetto delle loro riflessioni. Ciò dicendo si appoggia alla lezione di Yosef Yerushalmi, quand’egli evidenzia l’inesistenza di un’idea di storia nell’ebraismo che non sia quella che si riconnette al transito intergenerazionale. Benbassa coglie un aspetto importante quando evidenzia, a più riprese, che il tipo di costruzione ideologica che si basa sulla vittima è permutata dal rapporto con il cristianesimo. Il volto sofferente e scavato di Elie Wiesel parla una lingua “cristologia”, assai in sintonia con il sentire di un pubblico i cui codici di interpretazione riposano sulla lezione evangelica piuttosto che su quella pentateutica e talmudica. La vittimologia, che si lega alla martiriofilia, istituisce in coloro che se ne fanno portatori una sorta di aura protettiva, ponendoli al riparo dalle dure lezioni consegnategli della storia medesima. Si ingenera così il paradosso di una storia senza tempo, dove la cristallizzazione dei ruoli diventa l’unica partitura recitabile. Ma è per davvero questa la natura della moderna Israele?