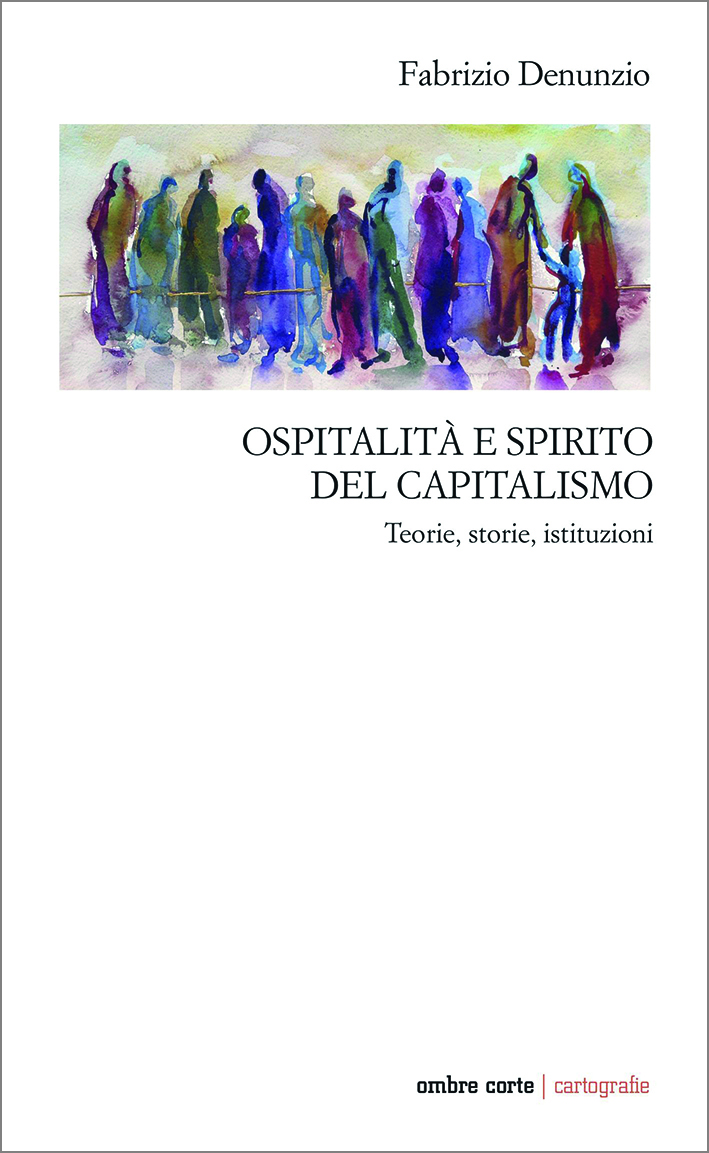Descrizione
Fabrizio Denunzio
Ospitalità e spirito del capitalismo
Teorie, storie, istituzioni
La globalizzazione ha intensificato i movimenti migratori internazionali negli ultimi cinquant’anni, portando all’attenzione delle coscienze e delle istituzioni il problema dello straniero. Di certo, l’Occidente non si è fatto trovare impreparato di fronte all’evento visto che, almeno dal xvi secolo in poi, aveva già messo a punto una serie di funzioni disciplinari con cui imbrigliare, addomesticare e sottomettere ogni forma di alterità: economica (i poveri), di genere (le donne) e di razza (i primi popoli colonizzati delle Americhe).
Il libro parte dal dibattito filosofico contemporaneo sul concetto di “ospitalità”, fortemente segnato dall’opera di Jacques Derrida, per poi rintracciare negli studi storici e sociologici classici sulla nascita del capitalismo alcuni dei momenti cruciali che hanno segnato l’inconciliabilità essenziale tra il suo spirito e ogni forma di accoglienza dell’altro. Un’accoglienza che non fosse mediata dall’internamento e dal profitto, ma, ancor più profondamente, dalla necessità di ridurre l’altro in modo gerarchico e verticale ai suoi valori, quelli del mercato. A tale riguardo rimane esemplare il trattamento che le borghesie europee riservarono ai poveri in ‘odore’ di peste in città come Troyes, Venezia e Parigi tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento.
La ricerca si chiude con un primo abbozzo d’indagine sulla storia del movimento operaio e sulle forme inedite di accoglienza di cui si è fatto protagonista.
Fabrizio Denunzio è professore associato di Sociologia dei processi culturali presso l’Università degli Studi di Salerno dove insegna anche Comunicazione e cultura dell’ospitalità. Ha tradotto saggi di P. Macherey, R. Williams, C. Lévi-Strauss, R.K. Merton e L. A. Coser. Tra i suoi lavori si segnalano L’inconscio coloniale delle scienze umane (Orthotes, 2018) e, con Ottavia Salvador, Morti senza sepoltura (ombre corte, 2019).
Rassegna stampa
Il Piccolo
I migranti insepolti attaccano al cuore la comunità che non riesce a ricordarli
La sociologa Ottavia Salvador è andata in Marocco dai parenti di Majid, morto dopo otto mesi di coma
Chissà se la sociologa Ottavia Salvador sta pensando di andare a trovare anche i familiari di Vakthang Enukidze, il 38enne georgiano morto il 18 gennaio scorso all’ospedale di Gorizia, dopo che era stato trovato privo di conoscenza al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca d’Isonzo. Il libro “Morti senza sepoltura” (Ombre Corte, 107 pagg.), scritto insieme a Fabrizio Denunzio, ricercatore in Sociologia dei processi culturali all’Università di Salerno, è stato pubblicato il 17 gennaio, giusto un giorno prima che il migrante morisse. Nello stesso volume Salvador ha dedicato un intero paragrafo a Majid, il marocchino deceduto nell’aprile del 2014 dopo un coma di otto mesi in seguito a un trauma cranico riportato nello stesso centro di Gradisca, al tempo si chiamava Cie. I parenti di Majid, quelli sì che è andata a trovarli, due volte, in Marocco, per la realizzazione del documentario “Ogni anima muore – Elegia per Majid”, da cui è poi nata la stesura di questo saggio.
Chi sono i “morti senza sepoltura” di cui scrivete?
Sono sia quelli che non hanno avuto alcuna sepoltura sia quelli che, pur avendola avuta, assumono, in diversi modi e per diversi motivi, uno status di insepolti. Soprattutto di questi ultimi, parla il libro.
Cosa significa non avere una sepoltura?
La tomba permette al defunto di essere identificato, e alla sua famiglia di tramandarne la memoria. Se non si garantisce al morto una sepoltura presso la sua comunità di riferimento, si attacca al cuore quella stessa società di cui egli faceva parte. Abbiamo fatto di questa particolare classe di defunti la lente attraverso cui guardare il fenomeno delle migrazioni e la causa storica che l’ha prodotto e lo riproduce, il colonialismo.
Migrazioni di oggi e colonialismo di ieri: come li affrontate? Sono due temi intrecciati.
Soprattutto se li si guarda attraverso la questione della insepoltura. Nel libro, v’è una riflessione a partire dalla ricerca etnografica che Ottavia ha condotto sulle morti nelle migrazioni attraverso una serie di storie, tra cui, appunto, quella di Majid. Fabrizio fa emergere gli stessi temi attraverso un’analisi socio-culturale del romanzo neocoloniale italiano (rappresentato, tra gli altri, dal capolavoro di Ennio Flaiano, “Tempo di uccidere” del 1947, la storia di un ufficiale italiano che uccide una donna etiope; fra i libri più importanti del Novecento, il cui titolo era in origine Il coccodrillo, nda).
Migrazioni e colonialismo: quale nesso?
La connessione è stata stabilita da Abdelmalek Sayad, considerato, in Francia, un nume tutelare della sociologia delle migrazioni. Sayad sostiene che tutti i processi migratori dipendono da una colonizzazione diretta e anche indiretta, organizzata intorno al processo di decolonizzazione: quell’influenza imposta dai colonizzatori sui paesi colonizzati anche a imperialismo finito. In estrema sintesi, il fatto che le migrazioni vanno dalle aree più povere del mondo a quelle più ricche è segno della necessità di fuggire da povertà, guerre e carestie. Il problema è che nelle migrazioni si muore.
Nel libro v’è un excursus di morti lasciati insepolti durante il colonialismo.
Una serie di autori contemporanei parlano del colonialismo di ieri mettendo la lente di ingrandimento sulla mancanza di una sepoltura. Oltre a Mariam di cui parla Flaiano, c’è, per esempio, l’eritrea Zeb’hí Tanqualít raccontata da Carlo Lucarelli ne “Il tempo delle iene”. Crediamo che questi autori, e altri, siano un ottimo strumento di analisi per le migrazioni attuali.
Parliamo di Mariam?
Nel suo romanzo, Flaiano tratta il colonialismo italiano in Etiopia raccontando la storia di questa donna etiope uccisa da un soldato italiano. Quest’ultimo ne occulta il corpo, e lei scompare di conseguenza alla propria comunità di riferimento. È sepolta, ma allo stesso tempo insepolta. Diventa per il soldato (e per la società colonizzatrice) un’ossessione, simbolo della violenza coloniale che resiste ai processi di rimozione storica. I familiari avranno pace solo quando scopriranno il luogo di occultamento e potranno darle una “vera” sepoltura.
Poi ci sono i migranti che muoiono oggi.
Evochiamo coloro che sono scomparsi e che sono rimasti senza sepoltura negli attraversamenti di mari e terre. Tra questi anche quei morti che, pur essendo stati inumati in qualche cimitero o fossa comune, risultano comunque lasciati senza sepoltura per la propria famiglia, per il proprio gruppo sociale di riferimento, per la memoria collettiva.
Veniamo a Majid.
Incontrando in Marocco la sua famiglia, due anni dopo la sua morte, Ottavia ha visto che quella sepoltura nascondeva un lutto molto complicato: i suoi familiari più stretti non hanno potuto assisterlo mentre era in coma in un ospedale italiano (se non hai soldi, se provieni da un certo Stato, non ti danno passaporti e visti per viaggiare); non hanno potuto vederlo da morto (è stato vietato loro di aprire la bara in Marocco); non hanno potuto celebrare il rituale funebre secondo tradizione; non hanno potuto sapere la verità sulla sua morte, avere giustizia. Sua madre nutriva il dubbio che nella bara non ci fosse stato davvero lui: non l’aveva visto, non riusciva a materializzare il lutto.
Anche Vakthang Enukidze, il georgiano morto il 18 gennaio scorso, può essere annoverato tra i morti senza sepoltura?
Rispondiamo riportando tre frasi della sorella di Vakthang lette su Repubblica qualche giorno dopo l’accaduto: “A chi volete che interessi il destino di un immigrato”; “Me l’hanno ucciso”; “Vogliamo solo riavere la salma”. —