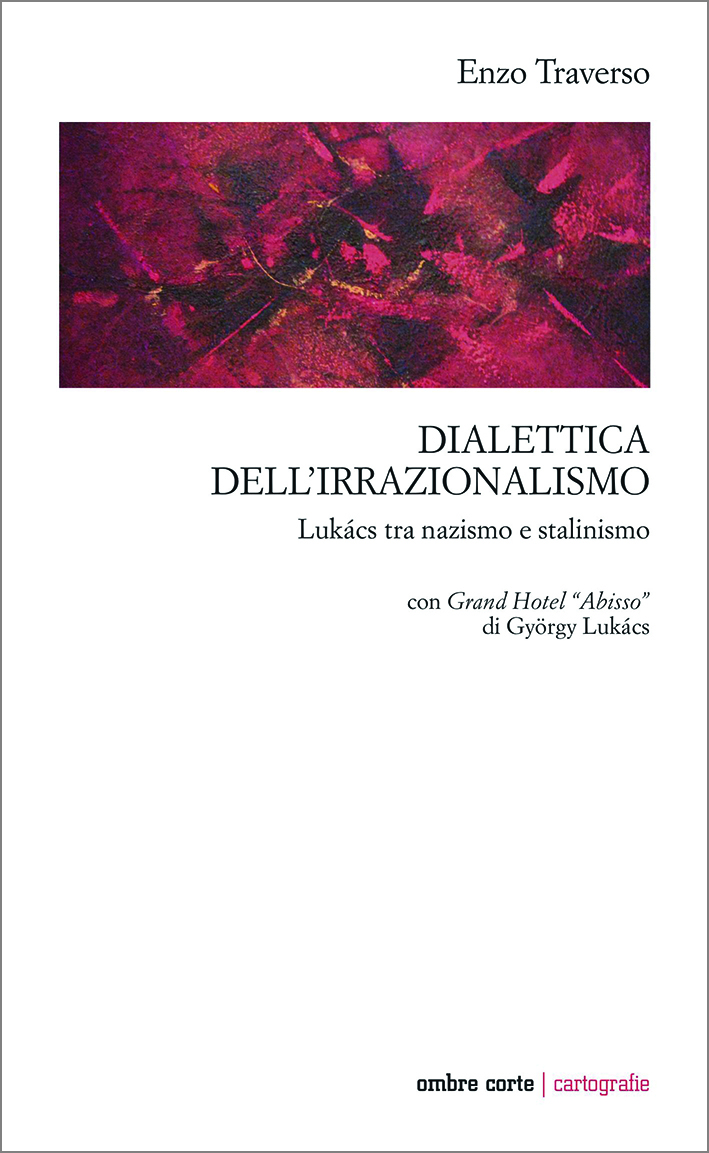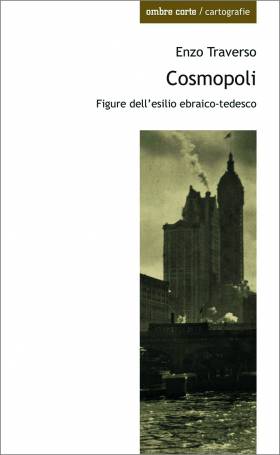Ormai perfettamente storicizzate, la parabola di György Lukács (1885-1971) e il suo grandioso lascito bibliografico sono divisi grosso modo dagli studiosi in quattro segmenti temporali:
il primo è del giovane formatosi a Heidelberg e al cospetto di Weber e Dilthey, firmatario di opere quali L’anima e le forme (1910) e Teoria del romanzo (’20), latrici di un romanticismo torrido e già proto-esistenzialista;
il secondo, poi prediletto in particolare dalla Nuova Sinistra, è del rivoluzionario che è entrato nel governo di Béla Kun e ha firmato Storia e coscienza di classe (’23), un’opera che recuperando il metodo dialettico libera l’eredità marxista dalle scorie sia del positivismo sia del revisionismo riformista;
il terzo è di colui che emigra a Mosca e assume via via un atteggiamento «nicodemico» e in pectore contraddittorio nei confronti dello stalinismo, dedicandosi prevalentemente a lavori di storiografia e di critica letteraria (fra i numerosi altri titoli, Il giovane Hegel, ’37, Il romanzo storico, ’38, Goethe e il suo tempo, ’49);
la quarta e ultima immagine di Lukács è finalmente relativa all’epoca della destalinizzazione e alla sua personale partecipazione alla insurrezione ungherese del ’56 cui segue un lungo autunno di sostanziale isolamento che tuttavia ne propizia i capolavori terminali, l’Estetica (Einaudi 1970) e specialmente la Ontologia dell’essere sociale (a cura di Alberto Scarponi, Editori Riuniti 1976-’81).
La ricezione italiana del filosofo, impossibile fino alla caduta del fascismo, è stata a lungo fervida (alcuni excerpta già erano comparsi nel «Politecnico» di Vittorini) e ovviamente segnata dal decorso politico e culturale del paese, soprattutto dalle vicende interne e dalla linea culturale del Pci, come attestano sia il volume monografico di uno dei suoi massimi esegeti, Cesare Cases (Su Lukács. Vicende di un’interpretazione, Einaudi 1985), sia da ultimo l’antologia curata da uno studioso benemerito, Lelio La Porta (Lukács chi?, Bordeaux Edizioni 2021).
Ma già nel ’59, in una rassegna intitolata Lukács in Italia (poi in Verifica dei poteri, 1965), Franco Fortini poteva scrivere che al di là delle interne discontinuità, delle fratture e delle sue stesse palinodie incontrare l’opera di Lukács, e del filosofo e del critico letterario, comunque equivaleva ad accettare «la proposta imperterrita di misurarsi con le massime dimensioni della storia umana e con le massime possibilità dell’uomo, di rinunciare all’apparenza per preservare quella sostanza che può tramutare noi, il nostro lavoro, e la società che fa tutt’uno con esso e con noi».
Ora, è da tempo di senso comune ritenere come la più caduca fra le grandi opere di Lukács, La distruzione della ragione (in Italia uscita da Einaudi nel ’59 nella versione di Eraldo Arnaud, poi riproposta da Mimesis nel 2011), quasi fosse un obolo offerto al regime di Stalin da parte di chi dal 1933 sopravvive in esilio a Mosca lavorando all’Istituto di Filosofia dell’Accademia delle Scienze e mantenendo per vent’anni un profilo bassissimo, ingrigendo la sua stessa prosa così come trincerandosi in un riserbo del tutto laconico, teste diretto il Victor Serge delle Memorie di un rivoluzionario.
È dunque un radicato luogo comune ritenere La distruzione della ragione (un lavoro concepito nei tardi anni trenta e pubblicato soltanto nel ’53 a Berlino, pochi mesi dopo la morte del tiranno) un’opera rozza, schematica e nella sostanza propagandistica come può esserlo una delle sue immagini vulgate, quella della SS cui la passione per Hölderlin (serbato addirittura nello zaino) non impedisce di scannare a man salva i cosiddetti Untermenschen. Insomma un’opera elettivamente e scientemente stalinista, se mai ce ne furono.
Tanto più radicato lo stereotipo quanto più utile, qui e ora, è la lettura dell’ottimo contributo di Enzo Traverso, Dialettica dell’irrazionalismo Lukács tra nazismo e stalinismo (Ombre corte, pp. 130, € 11,00) cui è annesso in appendice Grand Hotel ‘Abisso’, un testo propedeutico a firma di Lukács e in realtà allegorico, comparso in italiano soltanto nel 1989 per la versione di Vittoria Franco.
Con precisione, Traverso analizza la tesi lukácsiana secondo cui il Nazismo è l’esito nel lungo periodo della sistematica negazione di ogni presupposto razionalista e illuminista, distinguendo fra cause storiche (la vicenda tedesca come modernizzazione «anomala»), economico-sociali (nel connubio particolare di aristocrazia e borghesia), e infine culturali a partire dalla Restaurazione e cioè da un asse filosofico che da Schelling/Schopenhauer/Kierkegaard procede verso Nietzsche/Spengler/Heidegger ed esiti in cui si combinano apertamente darwinismo sociale e razzismo.
Ovvio, quanto a ciò, che agli occhi del filosofo l’unica alternativa praticabile è la via della dialettica che muove da Hegel (il quale scalza Kant al vertice dell’Illuminismo) verso la pratica rivoluzionaria teorizzata da Karl Marx.
Ci ricorda intanto Traverso che all’origine di quest’opera c’è un’interrogativa comune ai maggiori esponenti della cultura di opposizione: come è possibile Hitler? quale il terreno che ha visto nascere e prosperare la barbarie nazifascista?
A simili domande hanno risposto per altra via, fra i molti altri, Ernst Cassirer (La filosofia dell’Illuminismo, 1932), Siegrfried Kracauer (Cinema tedesco: dal gabinetto del dottor Caligari a Hitler 1918-1933, 1946) e gli stessi Adorno e Horkheimer (Dialettica dell’Illuminismo, 1947, dove si dice viceversa di una «autodistruzione della ragione») per tacere dell’amatissimo Thomas Mann che nel ’47 pubblica Doktor Faustus, un romanzo impensabile senza una drammatica ricognizione della demonologia nazista. (Non molti lo ricordano ma deve molto al vituperato libro di Lukács quello invece, e a ragione, fortunatissimo di Zeev Sternhell, esteso alla cultura francofona, Contro l’Illuminismo. Dal XVIII secolo alla Guerra Fredda, Baldini e Castoldi 2007).
Scrive, in proposito, Traverso: «Le discrepanze tra Lukács e Adorno, Arendt e Strauss erano certamente molto significative, ma tutti si erano ritrovati nello stesso campo durante lo spartiacque storico della seconda guerra mondiale, in un conflitto ideologico che, ben oltre due alleanze militari e politiche, opponeva due visioni del mondo: le forze dell’Illuminismo e quelle dell’irrazionalismo, l’alleanza provvisoria tra il comunismo e la democrazia liberale contro il fascismo».
Se Hegel aveva visto lo Zeitgeist in Napoleone a cavallo è probabile che Lukács volesse a un certo punto convincersi di averlo riconosciuto durante la guerra nel Piccolo Padre alla tribuna del Cremlino. Paradossalmente Lukács non analizza la cultura specificamente nazista e quelle che il suo amico Ernst Bloch chiamava «le latrine di Hitler» (a parte i riferimenti al Mito del XX secolo di Alfred Rosenberg), e altrettanto paradossalmente (ma questo è un chiaro segno dei tempi) egli non scrive una parola né sul colonialismo né sulla Shoah.
Perché allora riaffrontare La distruzione della ragione e scamparlo dal destino di grave infortunio da parte del grande filosofo o di arnese addirittura della Guerra Fredda? In tempi di contenzioso identitario, di anti-universalismo e insomma di anti-umanesimo, Enzo Traverso suggerisce che ha da insegnarci qualcosa, dopo tutto, quel libro uscito dalla guerra civile europea dove ancora si avvertono gli echi di Stalingrado.